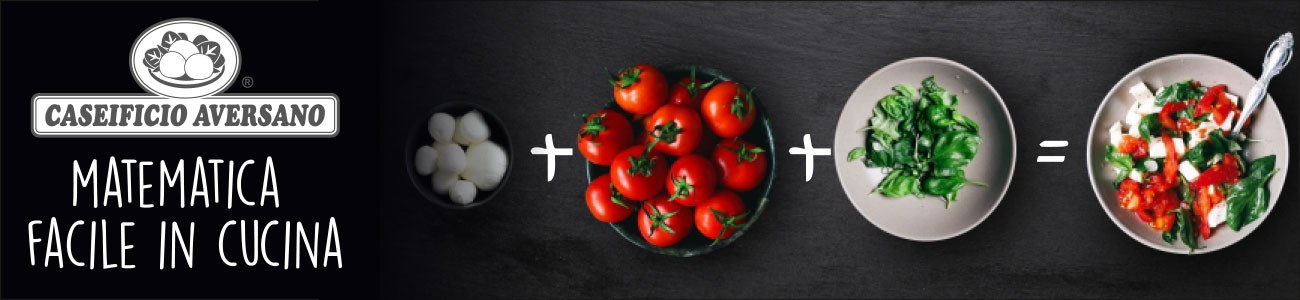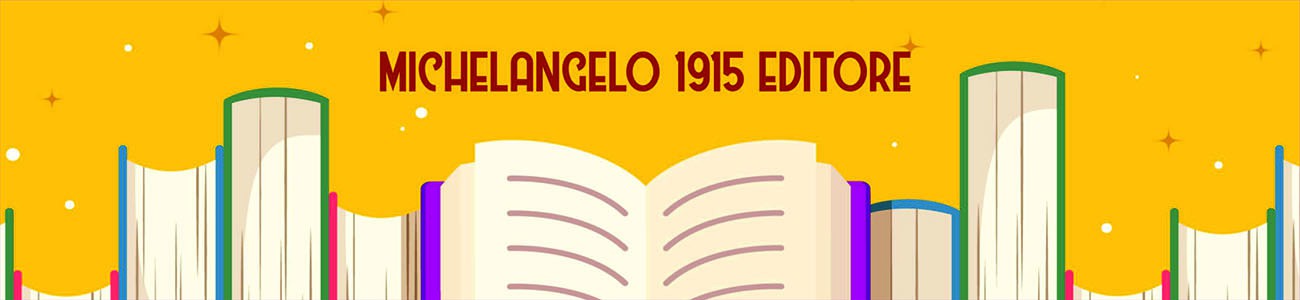IL WELFARE NEI REGIMI TOTALITARI: IL CASO ITALIANO DURANTE IL VENTENNIO
Giuseppe Montuori * 1 Giugno 2023
Il governo che Mussolini formò all’indomani della marcia su Roma non poteva far supporre che in pochi anni l’Italia sarebbe stata guidata da un partito unico e da una dittatura che, seppure non paragonabile ad altre esperienze totalitarie del XX secolo, seppe comunque mostrarsi molto dura con l’opposizione. Anche se dovette sempre fare i conti con forze a lui non omogenee (monarchia, Chiesa cattolica alte gerarchie militari, apparato diplomatico, grandi industrie, ecc.), il fascismo seppe imporre agli italiani un percorso che, iniziato con il varo delle leggi speciali (una serie di norme giuridiche, emanate tra il 1925 e il 1926, che iniziarono la trasformazione dell'ordinamento giuridico del Regno d'Italia nel regime fascista)[1], proseguì poi alla creazione di strutture istituzionali, giuridiche e sociali che avrebbero dovuto portare alla creazione dell’italiano “nuovo” auspicato dal fascismo.
Una nuova generazione di italiani che risaliva dall’antica Roma passava attraverso le glorie medievali, del Rinascimento e del Risorgimento, avrebbe finalmente espresso le proprie virtù eliminando i deficit storici che avevano – secondo il regime – ostacolato la crescita civile, morale ed economica del Paese. Proprio sul fronte economico il percorso del regime fascista si concluse in modo diverso da come si era inaugurato. Dopo esordi che non sarebbe azzardato definire di stampo moderatamente “liberista”, il fascismo, soprattutto dalla metà degli anni trenta (sia per la necessità dell’autarchia sia per le crescenti spinte in senso totalitario che si avvertivano nel partito), volle darsi una connotazione più originale attraverso la realizzazione del corporativismo[2], idea intorno alla quale intellettuali e studiosi di economia vicini a Mussolini si interrogavano da tempo.
Ma l’economia non fu solo un mezzo per rivedere l’assetto istituzionale dello Stato: da una parte la “difesa della Lira” (fine anni venti) e, dall’altra, le grandi iniziative in campo agricolo (dalle bonifiche alla battaglia del grano), mostrarono il tentativo del fascismo di misurarsi con la realtà in una congiuntura segnata dalla crisi mondiale del 1929[3]. In tutto questo, i rapporti tra regime e grande industria, non furono mai stretti e sinceri. La diffidenza era reciproca: i grandi industriali non vedevano di buon occhio le tendenze stataliste e dirigiste di Mussolini (che portarono alla creazione di istituti come l’IRI di partecipazione pubblica a imprese in difficoltà). Questi dati ci dicono in primo luogo che, anche durante il periodo fascista, l’Italia continuò a muoversi e a svilupparsi secondo le linee di tendenza comuni a tutti i paesi dell’Europa occidentale, benchè con ritmo più lento rispetto al ventennio precedente.
Nonostante l’invito a non abbandonare le campagne, si accentuò l’urbanizzazione, con una caduta degli occupati nell’agricoltura rispetto agli addetti al terziario, all’industria e nella pubblica amministrazione. L’arretratezza economica e civile della società italiana fu per certi aspetti funzionale al regime e all’ideologia fascista, o quanto meno ne favorì le tendenze conservatrici e tradizionaliste. Il fascismo, come il nazismo, predicò il ritorno alla campagna, esaltò la bellezza e la sanità della vita campestre, lanciò a più riprese la parola d’ordine della “ruralizzazione”, tentando senza riuscirvi, di scoraggiare l’afflusso dei lavoratori verso i centri urbani. Il fascismo inoltre, d’accordo con la Chiesa, difese ed esaltò la funzione del matrimonio e della famiglia, soprattutto come base per lo sviluppo demografico.
A tal proposito il regime identificava la potenza con la forza del numero, cercando in tal senso di incoraggiare l’incremento della popolazione. Infatti furono aumentati gli assegni familiari dei lavoratori, favorendo l’assunzione dei capi famiglia, furono istituiti premi per le coppie più prolifiche, istituendo addirittura nel ’27, una tassa sui celibi. In coerenza con questa linea, il regime ostacolò il lavoro delle donne (anche se con scarso successo) e, più in generale, si oppose al processo di emancipazione femminile. Anche le donne ebbero, durante il fascismo, le loro proprie strutture organizzative: quella dei fasci femminili, quella delle piccole italiane e delle giovani italiane (dipendenti dell’opera nazionale Balilla) e, più importanti di tutte, quella delle massaie rurali [4]. Ma si trattava di organismi poco vitali, la cui funzione principale stava nel valorizzare le virtù domestiche della donna, nel ribadirne l’immagine tradizionale di “angelo del focolare” diffusa attraverso la stampa, la letteratura fascista e i testi per la scuola. La dittatura mussoliniana costituì un episodio del dominio patriarcale, nel quale la donna era sottomessa all’uomo, il quale ne controllava i diritti (come cittadine), la sessualità, il lavoro salariato ecc.
La presenza femminile nel mondo del lavoro, crebbe incredibilmente quando milioni di donne furono mobilitate dall’economia di guerra. In seguito le donne trovarono maggiori spazi nei lavori impiegatizi, evento questo che permise l’avvento di una maggiore libertà a favore della donna, sia in ambito sessuale che sociale. Le donne all’interno della società ricoprivano diversi ruoli, in qualità di madri, mogli, cittadine, lavoratrici ed utenti dei servizi che lo Stato forniva. Si avvertiva quindi il bisogno di una ristrutturazione dei rapporti fra i sessi, permettendo alle donne di progredire. Nei governi occidentali ci fu una democratizzazione della figura femminile; la concessione del suffragio universale[5] fu un esempio per tutti. In Italia la dittatura mussoliniana considerava l’uomo diverso dalla donna e, non solo fisicamente. La differenza, naturalmente, era tutta a vantaggio dell’uomo, la donna infatti era considerata un oggetto a sessualità controllata, con meno diritti (soprattutto in ambito lavorativo), ed una minore partecipazione alla vita sociale.
Possiamo affermare che alla base del credo fascista, vi era proprio una concezione antifemminista, antiliberale e militarista, con molte analogie con quella nazista. La donna era vista come uno strumento da usare per fini sessuali, in particolar modo per fini riproduttivi, per una chiara strategia di consolidamento del potere nazionale. L’Italia fascista affrontò il problema dell’emancipazione della donna e della politica demografica ma, prendendo spunto da vecchi credi del passato. Al contrario la politica demografica svedese, aveva quale scopo principale una popolazione sana e stabile, senza l’assillo per le donne di dover ad ogni costo avere dei figli ma, una volta avuti, avrebbero goduto di ogni diritto, dagli alloggi a basso costo per i genitori, alle mense scolastiche gratuite, al diritto al lavoro anche per le donne, alla facoltà di poter abortire in caso di gravidanza non desiderata, legalizzando quindi l’aborto ecc. Inoltre fu attuato una forma di nazionalismo mite, contrariamente a quella italiana dove si cercava di ridurre al massimo l’acquisto di prodotti da Paesi stranieri, facendo leva sulle proprie risorse, ancorché non sempre sufficienti. Come in precedenza accennato, l’Italia affrontò il delicato problema demografico in termini mercantilistici[6], giustificando (il regime) le proprie idee in chiave di salvezza nazionale.
Lo Stato avocò a se tutti i poteri decisionali riguardo alla procreazione di figli. La politica economica del regime fascista era ispirata alla riduzione dei consumi di beni provenienti dall’estero e, favorire, quelli nostrani, cercando di imporre le gravidanze e proibendo l’aborto, la vendita di contraccettivi e l’educazione sessuale; favorendo a spese delle donne l’immagine dell’uomo all’interno della famiglia, nel mercato del lavoro, nel sistema politico e nella società in generale[7]. Abbiamo detto che il patriarcato (durante il governo fascista), affondava le sue radici nell’Italia post-unificazione, con la Chiesa che fino al 1904 si mantenne ostile al sistema liberale e contraria all’emancipazione femminile, anche se si mostrò protettiva nei confronti della donna, proponendosi quale campione dei valori della famiglia. Siamo in un’epoca in cui l’uomo era capo indiscusso della famiglia e dove le donne erano escluse dalla maggior parte degli atti giuridici e commerciali senza il consenso dei propri mariti, dalla possibilità di agire come tutori dei propri figli. Questo perché la paura dell’esaurimento demografico ed il declino della razza erano sempre vivi, nonostante che il tasso di fertilità italiano, stabilizzatosi intorno al 30 per mille, in ambito europeo era preceduto solamente da Spagna e Romania.
Il fascismo italiano fu un movimento camaleontico, infatti dapprima aveva abbracciato posizioni futuristiche nei confronti della donna, sostenendo il divorzio, la soppressione della famiglia borghese, parlando anche di suffragio universale femminile, abbandonando ben presto queste posizioni, in coincidenza dell’avversione mostrata dal movimento dei reduci anche nei confronti del lavoro femminile e delle antifemministe. Unica voce fuori dal coro era quella del tecnocrate del movimento, Giuseppe Bottai[8], il quale anche se non del tutto convincente difendeva l’uguaglianza della donna, aggiungendo infine che il partito aveva bisogno di compagne e madri valide per allevare i propri figli[9]. Nello stesso periodo l’Italia in campo economico imboccò la strada di una politica protezionistica. Evento quest’ultimo che accentuava ancor di più la doppia faccia della Nazione, con un sud povero che basava la propria economia su piccole imprese prevalentemente agricole, mentre al nord vi era la grande industria, che godeva anche di maggiori aiuti statali.
Alla metà degli anni ’30, quando il governo invitava i lavoratori a raddoppiare gli stenti per andare avanti, con il salario che rispetto agli anni ’20 era addirittura diminuito, si spendeva per le forze armate il 10% del reddito nazionale. Infatti nel 1938 il reddito reale degli operai industriali era più basso del 3% rispetto al livello del 1929, e del 26% rispetto al post bellico del 1921. Tra l’inizio degli anni ’20 e lo scoppio della seconda guerra mondiale, l’Italia fu l’unico paese industrializzato in cui i salari tendevano verso il basso. In questo particolare periodo storico, in cui la disoccupazione maschile era elevata, a farne maggiormente le spese fu naturalmente la manodopera femminile che, laddove era impiegata, era sottopagata. La politica dittatoriale oscillava tra riforme e repressione, pur non mancando gli incentivi statali. Fu fondata l’ONMI, vale a dire l’Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, si occupava principalmente dei fanciulli e delle loro madri che non rientravano nelle normali strutture familiari. Ancora vi erano le esenzioni fiscali concesse ai padri con famiglie numerose a carico (1933), i congedi e le previdenze statali in caso di maternità, i prestiti concessi in occasione di nascite e matrimoni, nonché gli assegni familiari erogati ai lavoratori stipendiati e salariati. Ancorché gli assegni ideati per integrare i redditi familiari incrementarono di poco i salari, erano destinati per lo più a chi aveva visto ridursi il proprio orario di lavoro ovvero aveva temporaneamente perso il posto di lavoro. Il premio era concesso al capofamiglia in base al numero dei figli, era erogato tanto ai lavoratori pubblici che privati, naturalmente erano strutturati in modo tale da indurre le famiglie ad innalzare il numero dei figli per godere di tali concessioni. Fece il suo esordio il prestito matrimoniale (dal 1937), che andava restituito in rate annuali, ma che alla nascita del secondo figlio veniva ridotto del 30%, fino alla totale cancellazione all’arrivo del quarto figlio. Infine i premi di natalità introdotti nel 1939. Le misure repressive compresero il fatto di trattare l’aborto come un crimine contro lo Stato, la messa al bando del controllo delle nascite, la censura dell’educazione sessuale e, una speciale imposta sui celibi. Quest’ultima tassa, imposta nel 1939, era pagata da circa un milione di uomini, per una entrata nelle casse dello Stato pari a 230 milioni, a fronte dei 260 elargiti a favore dei capifamiglia. Veniva condotta, ancorché in maniera forzata, una redistribuzione del reddito tra celibi e sposati con prole[10].
Altro incentivo era l’avanzamento di carriera per i padri di famiglie numerose, misura che fu giudicata particolarmente punitiva sia nei confronti delle donne disoccupate che verso gli uomini scapoli o senza prole. In questi anni il regime pose in essere una particolare politica nei confronti dei disoccupati, cercando di frenare le migrazioni dai luoghi di residenza, in particolar modo dalle campagne verso i grandi centri urbani, avvalenti anche dei contratti di mezzadria. Il risultato fu di spingere le famiglie verso le campagne e quindi verso zone più a basso consumo, rafforzando la coesione familiare e utilizzando i campi come unico mezzo di sostentamento, senza peraltro fruire dei sussidi municipali. Alla fine degli anni ’30 esistevano numerosi organismi statali e di partito ai quali le famiglie in difficoltà potevano rivolgersi in caso di bisogno: l’INFPS[11] , l’IPAB, INA, la CRI, l’INFAIL, ecc. Il regime d’intesa con i comuni, aveva anche predisposto di far trascorrere l’estate nelle colonie marine elioterapiche ai figli di famiglie bisognose. Considerato che la maggior parte delle famiglie non versava in condizioni floride, vi fu una consapevole dipendenza dai servizi dello Stato e una forma di gratitudine nei confronti del regime. Nel 1938 le lavoratrici avevano diritto ad un congedo di maternità della durata di due mesi, pari alla paga percepita in questo periodo, a un congedo non retribuito lungo fino a sette mesi, e a due pause giornaliere per l’allattamento finchè il bambino non avesse compiuto un anno. Infine furono rese più severe le norme che proibivano i lavori notturni alle donne e quelli più nocivi alla salute delle ragazze di età inferiore ai 15/20 anni e ai maschi sotto i 15 anni. Il provvedimento sicuramente più duro fu il decreto del 15 settembre 1938, il quale prevedeva che a partire dal 1940, negli uffici sia pubblici che privati non poteva lavorare più del 10% della forza femminile. In realtà questo provvedimento non trovò pratica applicazione perché la sua attuazione coincideva con il periodo bellico, durante il quale il lavoro delle donne fu di particolare importanza, visto che gli uomini erano in buona parte al fronte.
Tra le misure discriminatorie, va altresì ricordato che la legge fascista sul lavoro, vietava gli scioperi e curava direttamente le trattative sindacali. Concludendo, il fascismo intendeva riportare le donne al focolare domestico, condannando ogni forma di emancipazione femminile (dal voto, al lavoro extradomestico, al controllo delle nascite, ecc.), di libertà in campo politico, di poca considerazione dei sindacati, affrontando la questione demografica, considerandola (la donna) al servizio della Nazione al solo fine di procreare e allevare figli, i quali sarebbero poi divenuti la forza del Paese[12].
Tuttavia, l’intensa battaglia demografica e natalista del regime fascista non ottenne i risultati sperati, poiché il tasso di natalità continuò la sua tendenza strutturale a calare, secondo un trend che ha caratterizzato tutti i paesi dell’Europa occidentale. Inoltre solo nel 1975, con la modifica del diritto di famiglia fascista, si passò dalla potestà del marito alla potestà (ora “responsabilità genitoriale”) condivisa dai coniugi. Nello stesso anno fu abolito il divieto alla propaganda e all’uso di mezzi contraccettivi e l’aborto [13] non fu più reato contro la razza.
[1] Il Gran consiglio del fascismo, presieduto da Mussolini, composto da vari notabili del regime, era l'organo supremo del PNF (Partito Nazionale Fascista che con Regio Decreto n. 1848 del 6 novembre 1926, prevedendo lo scioglimento di tutti i partiti, divenne l’unico partito esistente ) e quindi dello Stato, a seguito della legge n. 2693/1928;
[2] Il Corporativismo fascista è una teoria economica espressa nella Carta del Lavoro (1927) che si poneva come ipotetica alternativa tra il capitalismo liberale e il comunismo. Lo Stato fascista aveva la funzione di regolare l'economia del paese e di anteporre all'interesse individuale quello nazionale;
[3] Crisi del ’29” detta anche “Grande depressione” o “Crollo di Wall Street”, ci si riferisce alla crisi economica che alla fine degli anni venti colpì l’economia mondiale riducendo su scala globale produzione, occupazione, redditi, salari, consumi e risparmi. L’inizio della grande depressione coincide con il pesante crollo che si abbatté sulla Borsa di Wall Street, da molti individuato più come un segnale che come una causa della depressione;
[4] G.Sabbatucci, V,Vidotto – Storia Contemporanea – Il Novecento, ed. Laterza, p.143;
[5] Il suffragio universale è il principio secondo il quale tutti i cittadini, di norma al raggiungimento della maggiore età, possono esercitare il diritto di voto e partecipare alle elezioni politiche e amministrative, e ad altre consultazioni pubbliche come i referendum, senza alcuna restrizione;
[6] Il mercantilismo fu la politica economica prevalente in Europa dal XVI al XVII secolo, basata sul concetto che la potenza di una nazione sia accresciuta dalla prevalenza delle esportazioni sulle importazioni (in termini economici di uso comune si parla di surplus commerciale).
[7] V. De Grazia – Le donne nel regime fascista – ed. Marsilio, p. 23;
[8] Giuseppe Bottai (Roma, 03/09/1895 – Roma, 09/01/1959), è stato un politico, militare e giornalista italiano. Fu governatore di Roma, governatore di Addis Abeba, ministro delle corporazioni e ministro dell'educazione nazionale;
[9] Françoise Thebaud – Storia delle Donne - Il Novecento – ed.La Terza, p.153;
[10] P. Dogliani – L’Italia fascista 1922-1940, Milano, Sansoni 1999, p.242;
[11] Nel marzo 1933 il governo fascista guidato da Benito Mussolini modificò il nome della “Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali” in “Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale“, quello che oggi chiamiamo INPS (privato dell'aggettivo di caratterizzazione politica);
[12] Nel famoso discorso dell’ascensione del 26 marzo 1926 Mussolini dichiara, tra l’altro, “……. il numero è la forza dei popoli .…”;
[13] La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 aveva consentito il ricorso all’IVG (interruzione volontaria della gravidanza), per motivi gravi motivando che non era accettabile porre sullo stesso piano la salute della donna e la salute dell’embrione o del feto.
* (Dottore in Scienze della Pubblica Amministrazione)